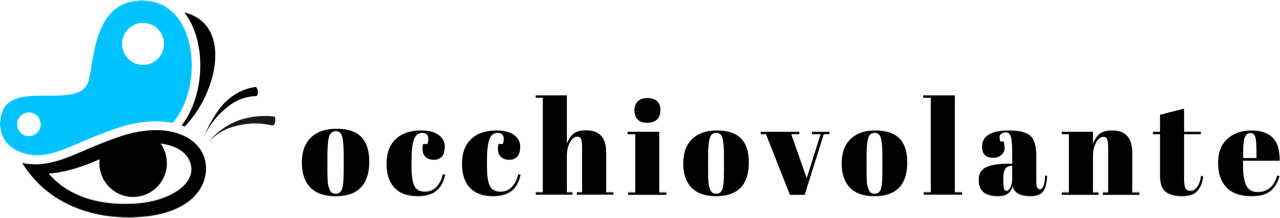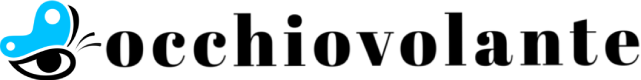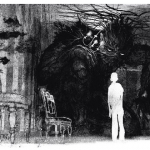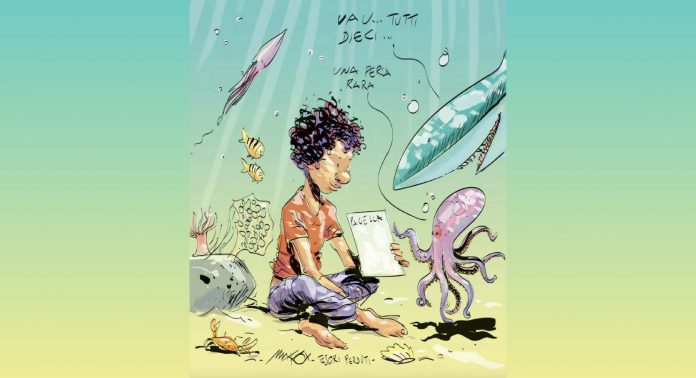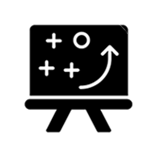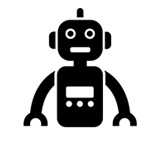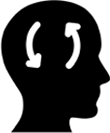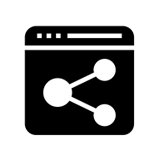Black Boys, la seduzione dell’odio

Perché dobbiamo leggere Black Boys di Gabriele Clima in classe.
Chi insegna sa bene che non può esimersi dall’affrontare con i propri alunni argomenti scottanti come il dolore della perdita, l’odio, la vendetta, la discriminazione, la violenza, la morte; sa bene che non può non srotolare i fili delle emozioni più perturbanti che nella vita di tutti noi si dispiegano, nonostante noi.
Siamo vulnerabili, tutti piegati da un vulnus che esiste proprio perché siamo vivi e, nonostante il mito di onnipotenza in cui tutti noi siamo cresciuti, l’imprevedibilità della vita può abbattersi in qualsiasi momento su chiunque.
Con i nostri alunni quindi credo sia doveroso provare a dipanare questa massa scottante proprio perché ci attraversa, anche se negli ultimi anni l’abitudine al politicamente corretto è approdata anche nella scuola. Ma come farlo? Attraverso il sermone del docente, il quale spiega che odiare è sbagliato, che amare e perdonare è bello e che la vendetta è da delinquenti?
Io ho sempre pensato che siano le storie, quelle raccontate in un libro o quelle che si vivono attraversando un film o una serie tv, a venirci incontro; sono le storie ad aiutarci a guardare fuori e dentro, che ci leggono e che hanno la straordinaria capacità di dare i nomi alle cose, anche a quelle più inverbalizzabili.
Come dice Recalcati, leggere…
“è un’esperienza che può coinvolgere profondamente il lettore: quando leggiamo un libro possiamo fare l’esperienza di sentirci nello stesso tempo letti dal libro che leggiamo. Sicché impariamo qualcosa di chi siamo dal libro che leggiamo perché noi stessi in fondo siamo un libro che attende di essere letto. Anche in questo senso la lettura è un’attività dell’io che però implica sempre l’incidenza dell’inconscio […] trovo nel libro le parole per dire quello che oscuramente vivevo e pensavo senza essere in grado di nominarlo”
M. Recalcati, A libro aperto. Una vita è i suoi libri.
E Black Boys è uno di quei libri che ha questo potere. Un libro che in superficie ha l’impostazione del romanzo per ragazzi, per via del linguaggio scorrevole e immediato, e perché i suoi personaggi sono ragazzi, ma la ricchezza dei temi e la profondità con cui vengono trattati rendono questo romanzo adatto a tutti.
Il protagonista è Alex, un ragazzo come tanti, con una famiglia normale e una vita normale, ma un giorno accade che nella sua vita irrompe il trauma della perdita. Un incidente stradale gli porta via il padre, lascia alla madre delle lesioni permanenti e lui è vivo per miracolo. L’incidente è stato causato da uno scontro con un furgone guidato da un uomo di colore, un “nero” di cui Alex conosce solo il nome: Mbaye.
Tutto cambia nella sua vita e a 16 anni Alex deve fare i conti con il lutto e la separazione. Il dolore è insopportabile, le parole non servono, anche se sono le parole di quelli che il lutto lo hanno già attraversato, perché tutti siamo diversi e ognuno ha “un suo modo”. Le possibilità che si aprono di fronte ad Alex sono due, una lunga e tortuosa, un’altra semplice e in qualche modo anche appagante che nega i tempi lunghi e labirintici del lutto e che ti offre anche la sensazione della potenza: questa è la strada dell’odio, la strada della vendetta.
Alex vuole trovare il responsabile di quell’incidente, quell’uomo che, secondo lui, continua a vivere la sua vita come se nulla fosse mai accaduto, mentre la sua vita e quella di sua mamma sono state distrutte. Alex vuole liberare quel fluido di rabbia e dolore che lo schiaccia, colpendo quell’uomo, urlandogli contro, pensa che quella sia giustizia, ma non sa come fare.
È cosi che si ritrova in un gruppo di ragazzi che quel ‘nero’ potrebbero trovarlo e questi sono i Black Boys. I Black Boys fanno quello che nessuno ha il coraggio di fare: “ripuliscono le strade dalla merda, cercano i neri, zingari, immigrati. E gli fanno capire che non sono i benvenuti”. Eppure Alex non è razzista, non gli importa nulla del colore della pelle di Moussa, lui vuole solo vendicarsi.
Ma la vendetta è così, si lascia guidare dalla via breve dell’odio, quella che ti fa credere che esista un Altro da eliminare per risolvere il problema, quella che ti fa credere che il mondo si divida in maniera semplicistica in due forze contrapposte e irriducibili.
Alex si ritrova pertanto in questo gruppo e tocca con mano il potere della violenza. Il capo del gruppo, Ferenc, si offre di aiutarlo a trovare il Nero, ma vuole qualcosa in cambio: Alex dovrà partecipare alle spedizioni punitive che loro fanno. È così che Alex si ritrova ad assaporare il senso apparente di potere che ti offre la violenza, un potere però che in lui si sbriciola fra le mani non appena viene compiuto.
Non ci impiegherà molto Alex a capire che non è quella la strada, che l’esercizio della violenza non te lo fa passare il dolore, che la strada della vendetta è risolutiva solo all’apparenza perché il dolore per l’assenza non passa così. Ma uscire da un gruppo di squadristi non sarà facile e le azioni compiute hanno sempre delle conseguenze.
Questo libro affronta in maniera così cristallina tanti di quei temi, da quelli intimi ed eterni relativi al singolo, a quelli sociali e politici attuali, che leggerlo in classe con adolescenti come Alex (ma anche un po’ più piccoli), può essere solo un’occasione di crescita.
- Leggere questo libro è per esempio fare educazione civica e storia allo stesso tempo perché ci consente di capire come è facile la logica dei populisti e della politica di pancia.
Populista ed estremista è Ferenc, per esempio, che incarna perfettamente non solo il leader dello squadraccia, ma anche l’aspirante capopopolo, perché sa che per avere successo è necessario ‘dopare’ le masse facendogli credere che l’origine di tutti i problemi siano i diversi.
“No, Alex, il punto è un altro. Tu, la gente, la devi caricare, la devi far incazzare. Non devi darle Pericle, devi darle il doping. […] Quello che si dà agli sportivi. Dai il doping alla gente, Alex, falla incazzare, falla andare su di giri. E poi le dai un motivo per essere incazzata.
“Gli immigrati?” risponde Alex.
Ferenc sorride e risponde “Lo vedi, allora, che capisci?”.
- Ma leggere questo libro è anche parlare di amore.
Amore per chi resiste, come la mamma di Alex, una donna forte perché ha imparato a fare delle crepe del dolore qualcosa di prezioso, che si è spezzata però ha saputo resistere alla fragilità.
Amore per chi non c’è più ma con cui è possibile tessere dei fili invisibili.
Amore per l’altro, perché se attraversiamo la strada lunga del perdono, potremmo scoprire che la realtà è molto più sfaccettata di quanto immaginavamo e che quello che avevamo definito Nemico, forse non lo è affatto.
Immagine di copertina: da Libreria Volare
Proed015