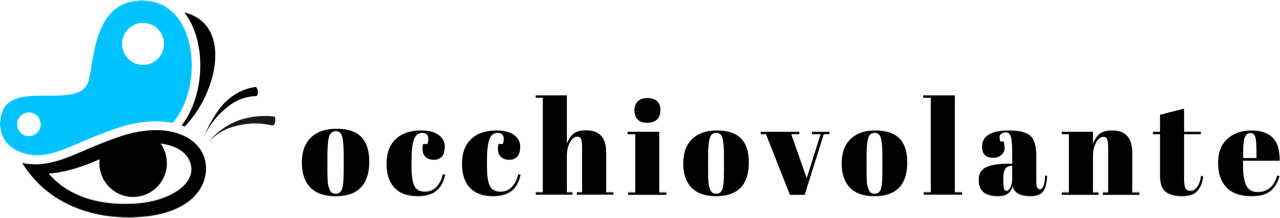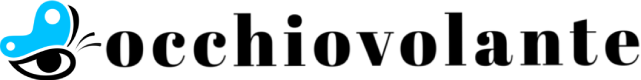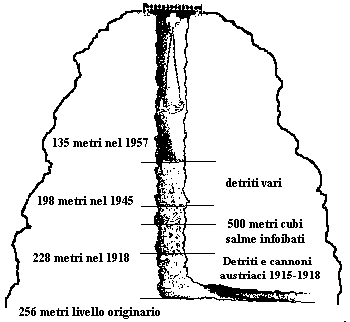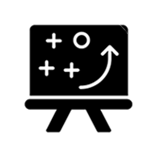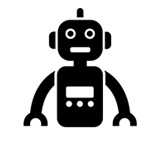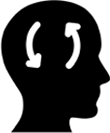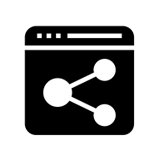Una riflessione su nuove categorie di Bisogni Educativi Speciali

Nelle scuole è stata introdotta la categoria dei “plusdotati”, studenti più intelligenti secondo test specifici, inclusi nei BES per i loro bisogni educativi speciali, rischiando concezioni divisive.
Oltre a quella di DSA e di BES (e forse di altre che al momento mi sfuggono) nelle nostre scuole è stata recentemente introdotta un’altra categoria, quella dei ”plusdotati”, ovvero gli studenti che – secondo appositi test – risultano essere più intelligenti (“di un’altra categoria”, verrebbe da dire) rispetto agli altri. Una categoria inclusa in quella dei BES visto che anche i più dotati avrebbero dei bisogni educativi speciali, terminologia con la quale si intendeva invece definire, in linea generale, il caso di uno svantaggio sociale od economico; qui invece si parla di alunni “gifted”, come sono definiti in modo per lo meno discutibile, come se ogni alunno non recasse in sé un dono proprio, particolare: dispiace davvero, questa definizione, che sembra recare tracce di una concezione divisiva se non discriminatoria e gerarchica della scuola e della società.
Una prima osservazione riguarda proprio questa ennesima introduzione di una terminologia che tende a classificare e a separare, giudicandoli particolari, degli alunni: c’è forse uno studente, infatti, che non abbia dei bisogni educativi speciali? Non sono tutti gli studenti dei casi particolari che la scuola, la classe deve riuscire a mettere insieme e a far collaborare? E, soprattutto, è così necessario immettere nel vocabolario scolastico continue definizioni che vogliono rappresentare una casistica di per sé infinita? Perché, infine, non si valuta la capacità degli insegnanti di discernere, capire chi si ha davanti senza dover fare ricorso a tabelle e specializzazioni le più varie? Non sono forse sempre esistiti, nella scuola, i casi speciali a cui si vorrebbe dare – non si sa bene come – una specie di tutela ulteriore?
Burocratizzazione continua
Mentre si va facendo sempre più alta, benché inascoltata, la voce che chiede una sburocratizzazione, ecco – in sintesi – che si vuole tassonomizzare un altro aspetto, da sempre esistito, della vita scolastica.
Vi è poi un problema più di fondo, o meglio più problemi di fondo, il primo dei quali è relativo alla domanda che sorge inevitabile: cos’è l’intelligenza? È davvero misurabile? I già citati test sembrano non dire poi molto, poiché il concetto stesso di intelligenza appare sfumato ed assai poco definibile, esistendo – tra l’altro – una pluralità di forme d’intelligenza, alcune delle quali impossibili da misurare e quantificare, come quella psicologica, quella emotiva, quella relazionale e così via (si veda il bel saggio di U. Galimberti Il mito dell’intelligenza, in I miti del nostro tempo, ed. Feltrinelli). A quale, dunque, dare la prevalenza? E perché solo ad una?
L’altra questione attiene al concetto stesso di scuola: non è che a forza di suddividere gli alunni in categorie a sé stanti si perde uno dei sensi dello stare a scuola, ossia lo scambio, l’ascolto, lo stare tra diversi eppure tra simili? Non è questa una delle missioni principali della scuola da quando esiste? Che poi, va detto, soluzioni miracolose ai bisogni educativi speciali non esistono: l’alunno più dotato (con le sfumature di significato non secondarie di cui sopra) incorrerà talvolta in una certa noia, così come non mancheranno le situazioni in cui gli svantaggiati avranno difficoltà a seguire le lezioni: ma forse è anche all’accettazione di questi fatti come normali e consustanziali alla vita scolastica, alla – si passi – sdrammatizzazione di dinamiche sempre esistite che si dovrebbe guardare.
Credits: Foto di Austris Augusts su Unsplash